COMITATI ETICI E SPERIMENTAZIONE CLINICA: NUOVE SFIDE NORMATIVE E RELAZIONALI

Il mercato giapponese del vino: le opportunità e le sfide per i produttori italiani
Ottobre 13, 2025
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE VORREI IN SANITÀ. RIFLESSIONI TRA INNOVAZIONE, ETICA E RESPONSABILITÀ
Ottobre 27, 2025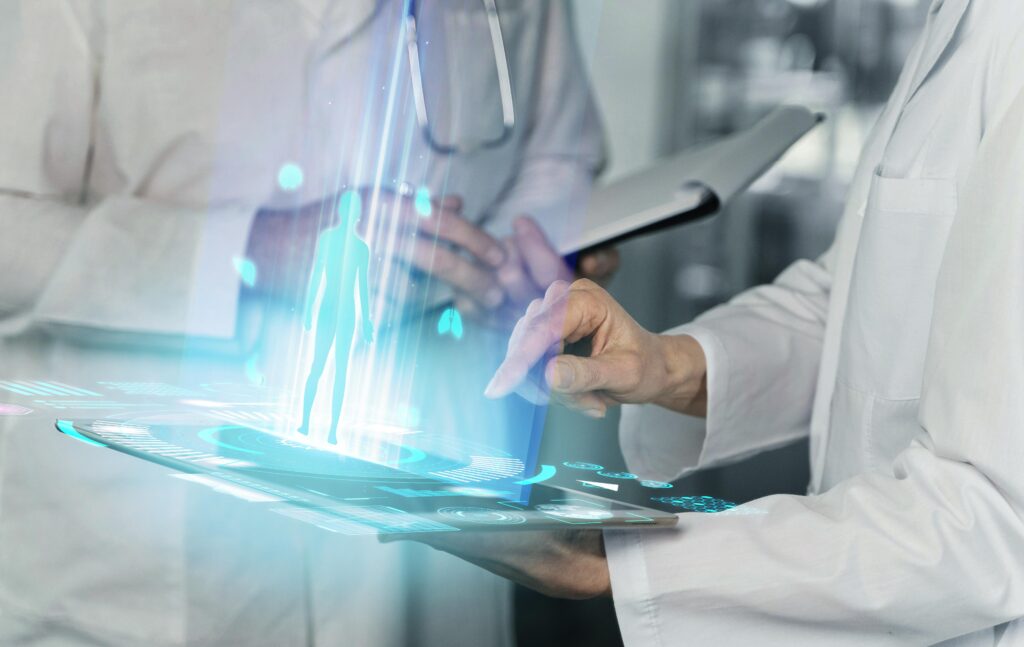
Il panorama della sperimentazione clinica in Italia sta vivendo una fase di profonda trasformazione, alimentata da nuove esigenze scientifiche, tecnologiche e normative. Il convegno tenutosi il 15 ottobre 2025 presso l’ASST Gaetano Pini di Milano, promosso da AFI e SIMeF, ha rappresentato un momento importante per riflettere sul ruolo dei Comitati Etici (CE) in questo contesto in evoluzione. L’incontro ha messo in luce le criticità che emergono nel rapporto tra sponsor / promotore dello studio clinico e il Comitato Etico competente, evidenziando la necessità di un ripensamento strutturale e normativo.
Il Regolamento (UE) n. 536/2014, entrato pienamente in vigore nel gennaio 2022, ha introdotto un sistema centralizzato per l’autorizzazione delle sperimentazioni cliniche, con l’obiettivo di semplificare le procedure, ridurre i tempi e favorire la competitività europea. In questo nuovo assetto, il ruolo dei CE è stato ridefinito: essi sono chiamati a esprimere un parere etico sulla sperimentazione, ma non più a gestire l’intero iter autorizzativo, che vede ora un ruolo centrale svolto dall’autorità competente nazionale. Tuttavia, il Regolamento riconosce esplicitamente l’importanza del parere etico, che deve essere reso in tempi certi e secondo criteri condivisi, per garantire la tutela dei soggetti coinvolti e la qualità scientifica dello studio.
Durante il convegno, è emersa con forza la necessità di rafforzare le competenze dei CE, soprattutto in relazione a nuove tipologie di studi che si discostano dalla tradizionale sperimentazione farmacologica. Studi su dispositivi medici, radiofarmaci, integratori, tecnologie digitali e intelligenza artificiale pongono interrogativi etici e metodologici complessi, che richiedono competenze specifiche e aggiornate. In molti casi, i CE si trovano a valutare protocolli che coinvolgono pazienti non coscienti, raccolta dati tramite app o interventi chirurgici in assenza di linee guida chiare o di una normativa consolidata.
Un passaggio particolarmente delicato riguarda il consenso informato, che il Regolamento 536/2014 considera elemento centrale per la validità etica della sperimentazione. Tuttavia, in situazioni cliniche complesse, come quelle che coinvolgono pazienti in terapia intensiva o non coscienti, la normativa non offre indicazioni univoche su chi possa esprimere il consenso in loro vece, se non nel caso di decesso, dove è ammesso l’uso dei dati. Questo vuoto normativo genera incertezza e richiede un intervento legislativo nazionale che chiarisca le modalità di acquisizione del consenso in contesti critici.
Un tema centrale emerso nel confronto riguarda la genesi e la storia dei Comitati Etici (CE) in Italia, che ha determinato nel tempo una frammentazione e un’eterogeneità strutturale protrattasi anche dopo l’adozione del Regolamento (UE) n. 536/2014. Nonostante già le Linee guida del Decreto Ministeriale del 1998 raccomandassero di evitare una proliferazione eccessiva, ad oggi risultano attivi 40 CE territoriali e 3 nazionali, oltre a Comitati Etici locali in Regioni come la Puglia e la Sicilia, spesso con competenze sovrapposte e approcci valutativi disomogenei. Inoltre la composizione dei CE, pur formalmente interdisciplinare, ha finito per riflettere più una logica di rappresentanza dei valori di ruolo e delle competenze individuali che una reale aderenza alle esigenze tecnico-scientifiche delle sperimentazioni. Ne sono derivate valutazioni discordanti tra CE, richieste di modifiche marginali a consensi e contratti, e perfino pareri negativi su studi già approvati da FDA o da altri CE europei.
In questo contesto, il Regolamento (UE) n. 536/2014, i decreti attuativi del 2023 e il ruolo del Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici territoriali rappresentano un tentativo concreto di razionalizzazione. Durante il convegno è stata rilanciata la proposta di istituire un parere unico nazionale per studi particolarmente complessi, come quelli con radiofarmaci, che richiedono competenze tecniche altamente specialistiche, non sempre disponibili a livello locale. Il tema dell’assenza di un parere unico valido su base nazionale è tuttavia ancora vivo anche per tipologie di studi molto comuni, come gli studi multicentrici osservazionali di patologia.
Il rapporto tra sponsor e CE è stato al centro di molte riflessioni emerse durante il Convegno. I CE non si limitano a valutare il protocollo, ma devono anche esprimersi sulla giustificazione terapeutica, sulla gestione della privacy e sulla comunicazione del rischio al paziente. In questo senso, è fondamentale che gli sponsor collaborino attivamente con i CE, fornendo documentazione chiara, classificazioni precise dei prodotti (in particolare se trattasi di dispositivi) e informazioni trasparenti sulle finalità dello studio.
Infine, il convegno ha offerto uno sguardo sul futuro della ricerca clinica in Europa, ricordando che per la strategia “Choose Europe for Life Sciences”, lanciata dalla Commissione Europea nel luglio 2025, sono aperte le consultazioni pubbliche sino alla fine di novembre. Questa iniziativa, sostenuta da oltre 10 miliardi di euro annui, mira a rendere l’UE il polo mondiale per le scienze della vita entro il 2030, attraverso investimenti in infrastrutture, biotecnologie, digital therapeutics e nuovi modelli di governance. In questo scenario, i CE italiani devono essere messi nelle condizioni di operare con efficacia, competenza e autorevolezza, per attrarre studi clinici di qualità e contribuire al progresso scientifico e sanitario del Paese.
La valorizzazione delle competenze, la formazione continua, la possibilità di consultare esperti esterni e la creazione di una banca dati condivisa di casi ed esperienze sono strumenti indispensabili per affrontare le sfide del presente e del futuro. Ma tutto ciò deve essere accompagnato da un’accurata individuazione dei requisiti necessari all’efficienza ed operatività dei CE soprattutto laddove servano competenze ad alta (e rara) specializzazione tecnica.
Il convegno non aveva l’obiettivo di indicare una strada precisa e condivisa per affrontare con successo gli studi innovativi e gli studi su ambiti medici altamente specialistici, ma ha sicuramente il grande merito di aver posto molti interrogativi sul tema e aver stimolato molte riflessioni perché qualche iniziativa che renda l’operato dei Comitati Etici progressivamente sempre più efficiente e qualitativo possa essere concretamente implementata.
BIOTECH ACT
La futura Biotech Act, annunciata dalla Commissione Europea nel contesto della strategia “Choose Europe for Life Sciences” presentata il 2 luglio 2025, rappresenta un pilastro normativo fondamentale per trasformare l’Unione Europea in un polo globale per l’innovazione biotecnologica entro il 2030 L’atto si propone di affrontare in modo sistemico le criticità che ostacolano lo sviluppo e la diffusione delle biotecnologie, intervenendo lungo tutta la catena del valore: dalla ricerca di base alla produzione industriale, fino all’accesso al mercato.Uno degli obiettivi principali della Biotech Act è la semplificazione del quadro regolatorio per le sperimentazioni cliniche e la bioproduzione. In particolare, si punta a ridurre i tempi di autorizzazione, armonizzare le procedure tra gli Stati membri e favorire l’adozione di tecnologie emergenti come le terapie geniche, le soluzioni digitali per la salute e i vaccini di nuova generazione. Questo si tradurrà in una maggiore prevedibilità per le imprese e in un ambiente più favorevole all’investimento privato.
La Biotech Act sarà strettamente integrata con altri strumenti europei, come il pacchetto farmaceutico e la futura Strategia per la Bioeconomia, prevista entro la fine del 2025. Mentre il pacchetto farmaceutico rivede la legislazione sui medicinali, la Biotech Act si concentra sull’ecosistema normativo e industriale, promuovendo la competitività e la sovranità tecnologica dell’Europa. In questo senso, l’atto fungerà da cornice generale per tutte le azioni legislative e non legislative successive, garantendo coerenza e sinergia tra le diverse politiche europee.
Un altro elemento chiave sarà la creazione di una piattaforma europea di incontro tra start-up, aziende consolidate e investitori, sostenuta dal Consiglio Europeo per l’Innovazione e dalla sua Trusted Investors Network. Questa piattaforma avrà il compito di facilitare l’accesso ai capitali, ridurre le barriere alla crescita e promuovere la collaborazione tra attori pubblici e privati. In parallelo, verranno mobilitati fondi dedicati per rafforzare le infrastrutture di ricerca clinica, accelerare lo sviluppo di materiali avanzati e sostenere la produzione di bioprodotti sostenibili.
La Biotech Act prevede anche misure per rafforzare la fiducia dei cittadini nell’innovazione biotecnologica. Verranno promosse campagne di comunicazione, iniziative di coinvolgimento pubblico e strumenti di governance dei dati per garantire trasparenza, sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali. In particolare, sarà istituito un Gruppo di Coordinamento per le Scienze della Vita, con il compito di garantire coerenza orizzontale tra le politiche in materia di salute, ambiente, concorrenza e ricerca.
Infine, l’atto riconosce il ruolo strategico dei Comitati Etici e delle autorità competenti nazionali, prevedendo interventi normativi per valorizzarne le competenze e favorire la specializzazione. In questo quadro, sarà fondamentale garantire che i CE siano in grado di valutare con efficacia le nuove tecnologie, gestire le questioni etiche emergenti e contribuire attivamente alla costruzione di un ecosistema europeo della ricerca clinica all’avanguardia.
In sintesi, la Biotech Act rappresenta un cambio di paradigma: da un approccio frammentato e reattivo a una visione integrata e proattiva, capace di rendere l’Europa un leader globale nel campo delle scienze della vita.

